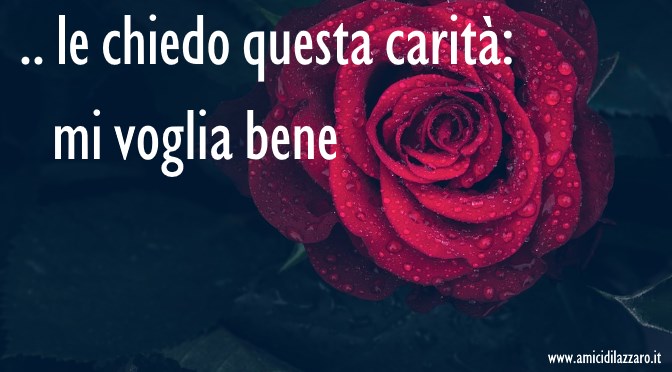
Alcuni giorni fa mi ha colpito una frase di Chesterton: «Colui che è convinto di essere in buona salute è l’unico veramente ammalato». Nel testo latino del Credo la liturgia mette sulle nostre labbra: «Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de Caelis». La traduzione italiana sostituisce il sostantivo “salutem” con “salvezza”, mentre per me la parola “salute” esprime molto bene la condizione dell’uomo già sul nascere della vita. Cristo non si è fatto carne solo perché l’uomo impari a guardare il suo destino finale, ma anche perché in questo momento possa godere della bellezza della realtà, della circostanza nella quale ognuno di noi è chiamato. Cristo si è fatto carne e vive in mezzo a noi affinché possiamo sperimentare in ogni momento la grazia della salute. Quella “salute” che abbiamo perso con il peccato originale. Dio si è fatto carne per ridarcela. Perché ciascuno sperimenti il gusto, la gioia di vivere, dentro qualsiasi situazione in cui ci troviamo.
Tutti siamo malati, ma quando il sacerdote versa un po’ di acqua sopra la testa di un bimbo e pronuncia la frase: «Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», non è più la morte il suo destino finale, ma inizia un’ontologia nuova che trasforma la mortalità in immortalità, la malattia – qualsiasi sia il suo nome – in salute. Ogni giorno vivendo con i malati terminali sperimento la bellezza di questa posizione, in particolare quando i pazienti non vogliono morire senza essere battezzati. È come se loro, abituati a vivere nella miseria, percepissero che senza il battesimo non possono morire in pace. Come quel musicista che alcuni giorni prima di morire ha composto una canzone nella quale afferma che vuole «morire cantando» per poter incontrare definitivamente quel Cristo che si è reso presente nella sua vita grazie al cancro che lo ha portato nella nostra Clinica. Lentamente, perfino il mio sguardo che prima non riusciva a stare di fianco a un moribondo, cambia radicalmente.
La lettera che segue è stata per me come una tempesta. Conosco bene cosa significhi ogni parola e il valore delle sue domande. Questo grido è stato per me come una spada che mi ha trafitto il cuore, che ogni giorno mi ferisce profondamente e se non avessi gli amici non riuscirei a convivere con il mio impegno neanche un secondo: «La prego, le chiedo questa carità: mi voglia bene». Quante volte abbiamo ascoltato don Giussani ripeterci: «La vita dell’uomo consiste in quell’affetto che principalmente lo sostiene e nel quale trova la sua più grande soddisfazione». Siamo stanchi della teoria, di appuntamenti con gli esperti della mente umana. Abbiamo bisogno, come afferma don Giussani in Ciò che abbiamo di più caro, di essere abbracciati da qualcuno la cui unica ragione di vita sia la gloria di Cristo. Il cristianesimo consiste esclusivamente in questo abbraccio di Gesù, presente nei tratti e nei lineamenti umani di chi, come san Paolo, ci testimonia che «per me vivere è Cristo», «tutto posso in Colui che mi dà la forza». «La prego, le chiedo questa carità: mi voglia bene». È una sfida per me e anche per tutti i lettori, molti dei quali vivono lo stesso dramma, perché convivere con un depresso senza offerta totale a Cristo è impossibile.
Carissimo padre Aldo, dopo aver assistito a un suo incontro, una cara amica mi ha consigliato di scriverle. Avrei voluto esserci anch’io, ma le mie non eccellenti condizioni di salute non me l’hanno permesso. Perché le scrivo? Perché lei è un uomo provato da una malattia come la depressione. Perdoni la mia schiettezza, ma quando si è con l’acqua alla gola i giri di parole non si tollerano più. Per favore, mi lasci rubare dieci minuti del suo tempo per leggermi.
È da 10 anni circa che non sto bene. Da un anno circa, posso dire con certezza, ovvero con diagnosi alla mano, “approvata” sia dalla psichiatra sia dallo psicologo, di soffrire del disturbo di personalità borderline. In 10 anni, uno dopo l’altro, uno assieme all’altro, si sono susseguiti tutti i “sintomi” di tale disturbo e di volta in volta mi sono concentrata su uno solo degli aspetti. È stato un annaspare continuo fra disturbi alimentari, autolesionismo, alcol, insonnia alternata a ipersonnia, senza la benché minima stabilità. Il fatto che una mia certa dose di pigrizia caratteriale si sommasse a una palese e dolorosissima difficoltà nel prendere anche le decisioni più banali e quotidiane (come alzarsi dalla sedia su cui non si sta facendo niente per farsi una doccia), mi ha portato a una discontinuità nella psicoterapia, anche a livello farmacologico, che di certo non ha aiutato, ma anzi ha spesso aumentato la frustrazione e la rabbia negli ultimi anni. E tutto questo è andato ad appoggiarsi su una base non solida, perché fino all’università ho “tirato avanti”, anche se arrancando, sostenuta dagli amici di Gioventù Studentesca e senza supporto medico di nessun tipo, per vergogna e anche perché mi ero rassegnata a etichettare quelli che erano sintomi come “caratteraccio e egocentrismo”. Insomma, quadrava tutto, mi sembrava, ci sembrava – a me e a chi mi stava intorno – fino al primo anno di università. Ero spesso arrabbiata, piangevo, mi sentivo perennemente in colpa, sbagliata, peccatrice e indegna, più volte ho cercato sollievo nei digiuni o nel dolore fisico, prendendo a scusante ricorrenze come il periodo pasquale o qualsiasi cosa mi capitasse a tiro, distorcendone il senso a mio comodo.
Ricordo con dolorosa lucidità la mattina del 7 novembre del mio secondo anno di università in cui non sono riuscita a farmi bastare il doverismo per alzarmi e andare in università a studiare, a frequentare i corsi, a vedere quegli amici trovati lontano da casa. È stata una sola mattina, di cui ancora sento il peso, a incrinare definitivamente ogni automatismo. Forse è stato meglio così, perché a quel punto ho iniziato a cercare supporto medico. Ma ho perso sonno, salute, soldi, tempo e soprattutto la voglia di fare una cosa che mi piaceva: leggere, più scrivere e ancor più spiegare. Avrei voluto essere una professoressa. Avrei voluto ma non è andata così. Ho avuto grossi conflitti con alcune persone nel movimento, ho perso i contatti con gli amici di sempre, loro non mi cercavano, io non cercavo loro. Mi sono sentita sola. Ho provato per un po’ ad andare a Messa, a pregare, piangendo, ma ero sola, isolata, non riuscivo a reinserirmi. Ci ho provato, padre, davvero, a rimboccarmi le maniche: ho cambiato città, cercato persone, provato ad avere nuovi amici, ad andare in terapia, ho preso farmaci, ho tentato di restare aggrappata alla musica (mia grande passione), ma non c’erano basi, non ci sono nemmeno ora, ed è stato un fallimento reiterato su tutto il fronte.
Sono dovuta tornare a casa, arrendermi all’idea di non finire l’università, di aver perso ogni passione, dare un grosso dispiacere alla mia famiglia. Ho iniziato a lavorare, grazie ad amici del movimento che mi hanno vista crescere, in un doposcuola elementare. È bello, mi entusiasma, ma il mio umore è troppo traballante perché questo basti. Ogni giorno è una lotta con me stessa per non cedere alla tentazione di svicolare dal dovere, assentarmi, a volte anche proprio per il limite fisico imposto dal non riuscire a dormire per giorni o, al contrario, non poter fare a meno di dormire più di dieci ore. La salute è diventata cagionevole, il corpo non regge più bene: mi ammalo spesso e ho tutta una serie di acciacchi che mi impediscono di avere la vita che si dovrebbe avere alla mia età. Sono stanca, padre, sono stanca e non nego di aver pensato più volte a soluzioni estreme, che soluzioni poi non sono. Non riesco nemmeno a parlarne esplicitamente tanta è la vergogna, però succede che chieda a Dio di darmi tregua, anche definitivamente… Sono arrabbiata con chi ha una vita normale, non riesco a voler bene a qualche amico, perché l’invidia è forte e il senso di ingiustizia anche. Perché a me? Non chiedo neanche più di avere una vita “sana”, ma una vita “così così”.
Mi chiedo se ne vale la pena, se mi interessa, perché io di buono, nella mia vita, non vedo nulla. Tutto intorno sì, è innegabile… Ma perché per me no? Che cosa ho fatto di tanto cattivo? Non riesco a far pace con me stessa o a perdonarmi di esser malata. Eppure faccio questo tentativo, che è uno dei più impensati, dato l’imbarazzo che provo per la mia condizione, perché mi è stato detto che lei non è estraneo a tutto questo dolore che ti si artiglia nel cervello e nel cuore e nelle ossa e nei muscoli e non ti dà pace, perché lei ha costruito tanto nonostante tutto… E allora, magari, anche io…
Ecco, la prego, le chiedo questa carità: mi voglia bene. Mi prenda a cuore come quei bambini del San Rafael. Iniziamo una corrispondenza, mi aiuti a non restare sola con me stessa, a confrontarmi, mi aiuti ad avere un appuntamento fisso, epistolare, con lei. Non le voglio rubare molto tempo, andrà bene qualsiasi condizione lei deciderà. Solo, la prego, non mi lasci da sola con me stessa, non mi sopporto più.
Lettera firmata
Aldo Trento- 2013 – Tempi

Per abbonarsi : Abbonamento con carta di credito – Tempi

