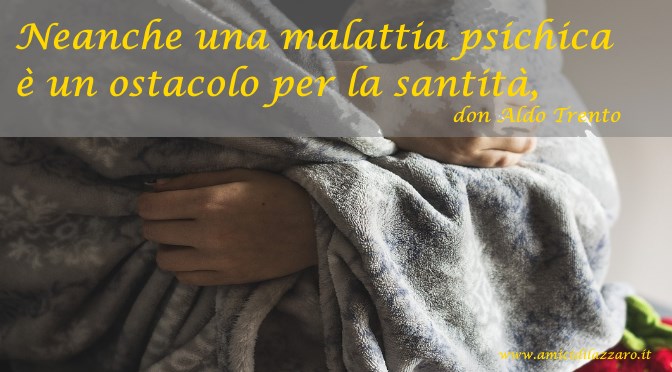«Perché devo soffrire tanto Signore?» domandava santa Teresa d’Avila a Gesù in un momento di grande sofferenza. Ed il Signore rispose: «Perché ti amo molto Teresa». La Santa, che non ha perso mai l’ironia neanche nei momenti più drammatici della sua vita, gli rispose con estrema sincerità: «Oh Gesù mio, allora preferirei che Tu mi amassi un po’ di meno». Ho ascoltato queste parole una settimana fa quando, dopo essere atterrato all’aeroporto di Malpensa, a Milano, sono andato come di consueto nel paese di Trivolzio dove si trova il santuario con il corpo di san Riccardo Pampuri, per confessarmi. Avevo sentito parlare di tanti aspetti della santa d’Avila, delle sue penitenze, della sua contemplazione e del suo misticismo, della sua attività instancabile, ma mai del suo rapporto umoristico con Gesù. Mi ha fatto molto bene, perché è splendido scoprire che i santi sono uomini e donne come noi, con gli stessi drammi, con le stesse problematiche, con la stessa stanchezza quando il dolore colpisce profondamente. È bello osservarli nella loro vita quotidiana e scoprire che soffrono ciò che soffriamo tutti, che chiedono al Signore che gli venga allontanato il dolore e che, a volte, arrivano perfino a lamentarsi. Ciò vuol dire che sono umani, non sono eroi, parola che si oppone al sostantivo santo. L’eroe è un fantasma, un’illusione, una menzogna, mentre il santo è l’uomo reale, l’uomo che vive tra le vicissitudini di questo mondo con lo sguardo fisso là, dove c’è la vera gioia, come recita una colletta della Messa. Il santo, ha detto Giovanni Paolo II parlando di san Benedetto, è «l’uomo che vive l’eroico come quotidiano ed il quotidiano come eroico». E questo coincide con la casalinga, con l’impiegata, con lo spazzino, con il malato, con il professore, con il bottegaio, con qualsiasi persona che viva intensamente il reale. Cioè la santità è possibile in qualsiasi stato o condizione della vita in cui l’uomo è chiamato a vivere.
Per noi, abituati ad ammirare i santi rappresentati nelle immagini o a considerare tali esclusivamente quelli che il Papa santifica, è molto difficile questa posizione. Ma anche le persone proclamate sante dalla Chiesa sono semplicemente persone, appartenenti allo stesso mondo in cui viviamo noi. Tra loro ci sono tutti i tipi di persone, appartenenti a tutti gli strati sociali, ci sono sposati, nubili e celibi, consacrati, gente semplice, professionisti, scienziati e persone umili. La santità per la Chiesa è la vita ordinaria, vissuta con lo sguardo fisso verso il destino ultimo, con la coscienza che siamo proprietà di Cristo. Quando penso a mia madre, non posso non pensare alla sua santità. Lei non ha fatto niente di eccezionale, era una povera ed umile casalinga che si è occupata di suo marito, mio papà e dei suoi cinque figli e che alternava i lavori domestici con quelli del campo, andava a Messa e recitava il rosario ogni giorno. Non aveva tempo di partecipare a ritiri spirituali, né a nessun’altra forma di aggregazione parrocchiale, ma nonostante questo la parrocchia è stato il luogo in cui si è rafforzata la sua fede che testimoniava nella sua specifica vocazione matrimoniale e familiare. Quando ancora giovane si ammalò, imparò, tra i lamenti per il dolore, ad offrire. L’ho vista piangere a causa dei dolori fisici e morali, ma sempre dicendo: «Signore, te lo offro». Era una vera donna, perché il santo prima di tutto è un uomo, cioè un essere umano che vive intensamente il reale, guardando verso l’infinito. La sua unica preoccupazione è stata quella di cercare in tutto la gloria di Dio, vivendo la sua piccola condizione umana come un’offerta totale a Gesù. In quest’ultimo decennio è stato bello vedere come la Chiesa ha cominciato ad esporre sulla facciata della Basilica di San Pietro, circondata dalle colonne del Bernini, immagini di persone sposate proclamate sante, rompendo così la tradizione in cui sembrava che il matrimonio fosse un impedimento alla santità. Che commozione per me, quando hanno beatificato i genitori di Teresina del Bambin Gesù! Il papà di questa santa carmelitana, che ho imparato ad amare nella mia gioventù, è rimasto vedovo ancora giovane ed ha sofferto di disturbi psicologici a causa dei quali si alternava tra l’ospedale psichiatrico e casa sua. Ciò nonostante la Chiesa lo ha proclamato, insieme a sua moglie, beato e se Dio vuole presto santo. Questo è un esempio in cui notiamo che neanche una malattia psichica è un ostacolo per la santità, perché non esiste condizione fisica o psichica che impedisca totalmente e definitivamente quel minimo di libertà che permette all’uomo di riconoscersi nella frase: «Io sono Tu che mi fai». Durante questi anni di vita quotidiana con malati terminali con problemi fisici o psichici, non ho mai visto in loro perdersi completamente la possibilità di dire con me: «Tu, o Cristo!». Per questo nessuno è morto senza confessarsi, senza riconoscere la grande Presenza, senza abbandonarsi alla tenerezza del Mistero che si è fatto carne nelle loro carni, molte volte consumate dal cancro o dalle conseguenze dell’Aids. Guardando i miei figli che soffrono, vedo chiaramente cosa sia la santità e percepisco l’umorismo di santa Teresa d’Avila. Quanti di loro hanno avuto ed hanno la stessa posizione di questa santa! Ricordo Carlos, un gitano, che distrutto da un cancro al volto, prima di morire, ha composto la sua ultima canzone che ha intitolato Morire cantando. Quando la morte è arrivata a prenderselo, lui stava cantando nel suo cuore.
Mi ha commosso anche Cynthia, una ragazza molto giovane madre di due bambini, morta recentemente di Aids, o Bernardino, morto anche lui da poco per la stessa causa. Entrambi si sono preparati serenamente all’incontro con Cristo, quasi come un innamorato aspetta la sua fidanzata. Senza un lamento, ma con un’ironia fino alla fine: «Bernardino, sei ancora vivo?», gli chiedevo scherzando ogni volta che lo andavo a trovare e lui rispondeva: «Sì padre, sono ancora vivo» e dopo faceva il segno della croce. La sua vita era stata un inferno. Quando è arrivato in clinica le sue parti intime erano in pessime condizioni. Ricordo che una notte la dottoressa responsabile del reparto di malati di Aids mi chiamò, mentre stava accudendo Bernardino, e mi impressionò come gli stesse pulendo le parti intime che avevano cominciato un processo di decomposizione. Le chiesi: “Dottoressa, non le provoca nausea quello che sta facendo?” e lei mi rispose: “Padre, sto curando il corpo di Cristo”.
Cynthia quando è arrivata in clinica per morire, pesava soltanto 30 kg ed era cosciente del suo imminente incontro con Gesù. Per questo lo ha atteso, assistita da sua mamma, offrendo e pregando per tutti. Per lei il suo letto coincideva con l’altare su cui celebro la Messa, entrambi erano il luogo del sacrificio. Leggendo queste testimonianze uno può pensare: come è possibile che nella tua clinica tutto sia bello e positivo? Oppure: come uno può non esserlo, sapendo che il direttore generale è il Santissimo Sacramento e che la presenza di Cristo è più evidente del sole in una bellissima giornata senza nuvole?
La positività non è l’assenza di drammaticità, non è l’eliminazione del dolore, non è la censura delle terribili malattie dei pazienti o l’eliminazione dei gemiti causati dai dolori che provoca il cancro, ma è proprio il contrario. Tutto questo esiste, come esistono tutti i mezzi che la scienza ci offre per calmare o ridurre il dolore. Ma quando la vita di una persona è afferrata dal Mistero, attraverso la grazia di un incontro vivo, presente ogni giorno, in lei tutto acquista una positività. Il valore positivo di chi riconosce che il motivo per il quale si nasce, si vive, si soffre e si muore è la gloria umana di Cristo, la positività del dolore di Cristo. Senza di Lui perfino la cosa più bella del mondo perde senso, valore, ragione d’esistere. Quando San Paolo afferma: «Tutto posso in colui che mi dà la forza», vuole provocarci affinché possiamo sperimentare questa verità. Non vengono tolte le difficoltà, i dolori, le sofferenze, ma niente di questo impedisce di poter vivere tutto con una gioia piena di pace, di umanità, fino ad arrivare alla familiarità che Santa Teresa d’Avila aveva con Gesù. L’essere cristiano non è come una droga, un analgesico o la morfina per calmare il dolore della vita o per scappare dalla realtà, ma è un fatto che ci permette di dare senso alla vita in tutti i suoi aspetti e dentro ogni circostanza, anche nelle più dolorose. L’esperienza cristiana non toglie il dolore, ma gli attribuisce un senso.
Aldo Trento – Tempi

Per abbonarsi : Abbonamento con carta di credito – Tempi